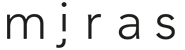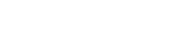Viaggiare nel tempo attraversando una città fantasma
Io sono semplicemente convinto che qualche parte del Sé o dell’Anima dell’uomo non sia soggetta alle leggi dello spazio e del tempo (Carl Gustav Jung)
Pyramiden, Pomona, Kalapana, Pompei, Monterano, Gessopalena, hanno nomi bellissimi questi luoghi, che risuonano come musica. Qualcuno le chiama città morte… eppure morte non lo sono affatto. Sono le Ghost Town, città fantasma, questo sì, perché vagando tra le rovine e il “quel che resta”, pare ancora di sentire aleggiare nell’aria le voci e i rumori della vita quotidiana.
Diverse eppure tutte simili, ciò che un giorno era stato un centro vivace e prospero ora si abbandona inerte all’abbraccio avvolgente della natura, che reclama impietosamente il suo diritto a riconquistare il dominio del territorio.
Suscita mistero, fascino, la città fantasma, e suggestione, e come è straniante avventurarsi tra le sue vie abbandonate che raccontano la Storia e le storie piccole, che ci testimoniano la vita e la bellezza spezzate e interrotte da disastri ambientali, calamità naturali, declino economico o terribili epidemie. Ragioni diverse ma sempre questioni di sopravvivenza hanno disegnato il loro oscuro destino decretandone la caduta senza tuttavia riuscire a spazzarle via.
Come fantasmi che danzano nel silenzio, tetramente magnifiche, le città fantasma ci parlano della caducità della vita e insieme della sua ostinata sopravvivenza. Il riappropriarsi della natura di spazi e luoghi e accanto il permanere ostinato della presenza dell’uomo nei suoi paesaggi.
Restano talvolta piatti e suppellettili, la pentola ancora sul fuoco, le finestre oscurate dalle tendine ricamate a mano.
Le pareti delle case deserte possono raccontare storie dimenticate, e i resti di una vita passata fanno risuonare l’eco di antiche risate. Camminarci attraverso è fare un viaggio nel tempo.
Improvvisamente cavalli bianchi si muovono dentro rovine che sembrano antichi templi, palazzi abbandonati i cui stemmi ricordano gli antichi fasti. Siamo a Monterano, vicino Roma. Ci è passato anche il Bernini qui un tempo, lasciando incastonate in palazzi e fontane la fama e il suo talento.
Tra tutte però Aquaresi è la mia preferita, forse per via di un richiamo ancestrale verso la terra degli antenati o perché mi ricorda l’infanzia e la vita in quei luoghi. Se sbarcate in Sardegna, tra una spiaggia e l’altra, raggiungete la costa sud occidentale, lungo i sentieri del cammino di Santa Barbara. Lasciate alle spalle Nebida e Masua, bisogna piegare a destra dove ci accoglie la grande montagna bucata. Tra gli sterpi bruciati dal sole, tintinnano i campanelli di un gregge di capre, unici abitanti di oggi di quello che fu, fino alla fine degli anni Cinquanta, un villaggio ridente e vivace sorto ai piedi della miniera.
Basta solo socchiudere gli occhi per vedere ancora la vita animare le strade, il vociare dei bimbi, le botteghe, il suono delle campane. C’erano persone in quei luoghi, nella piazza, a scuola, in ospedale; c’era la vita, scandita dai ritmi regolari e dalle semplici azioni del quotidiano. E poi, un giorno, non più.
La piccola elegante Chiesa in stile gotico-romano dedicata a Sant’Antonio è ora abbandonata dagli uomini e da Dio. Cosi come ogni abitazione, edificio, bottega, e il cinema, anche quello (che cosa eccezionale per quei tempi!) che ora non proietta più un film.
Camminare tra le rovine di Acquaresi è come un incontro con il passato, un viaggio attraverso le pagine di un romanzo dimenticato. Tra le pareti diroccate degli edifici, rivestite dai rampicanti tenaci, posso ancora percepire le emozioni rimaste incastrate nei mattoni, mentre il vento di maestrale che spira forte sembra portare via i ricordi perduti.
Alla fine, la città fantasma (ciascuna e qualunque) rimane un enigma irrisolto, un segreto sepolto tra le sue stesse mura silenziose. Forse, proprio in quel silenzio giace la vera essenza di ciò che è stato, tracce indelebili di un passato forse non poi così lontano, e di un futuro, il nostro, che forse è “già stato”.
Gina Ingrassia